Emergenza4 - Vegasoccorso
Menu principale:
Uomo
Parte IV URGENZE ED EMERGENZE DELL' APPARATO CIRCOLATORIO
Cenni di anatomia e fisiologia.
Dopo aver considerato le principali urgenze di due importanti apparati della vita umana il nervoso e il respiratorio parleremo di quello che è in stretta correlazione con gli altri due, il terzo apparato fondamentale, cioè quello cardio- circolatorio. Questo, assicurando la continua circolazione del sangue, consente di fornire a tutte le cellule del nostro organismo l'ossigeno necessario alla loro attività e alla loro vita e di asportarne l'anidride carbonica prodotta nel corso del loro metabolismo. Il trasporto dell'ossigeno proveniente dall'aria che respiriamo, avviene a opera dei globuli rossi tramite una sostanza in essi contenuta, l'emoglobina che, alternativamente libera ossigeno nelle cellule dalle quali assorbe anidride carbonica e libera anidride carbonica nei polmoni dove assorbe ossigeno. Il cuore, organo principale dell'apparato circolatorio, è una specie di sacca, poco più grande di un pugno, divisa internamente in quattro camere (2 atrii nella parte superiore e 2 ventricoli in quella inferiore) e in due settori (destro e sinistro, non comunicanti fra di loro). Gli atrii comunicano con i ventricoli sottostanti attraverso aperture controllate da valvole che non consentono, in un cuore sano, che il sangue refluisca una volta che è sceso. La parete della sacca è costituita dal muscolo cardiaco (miocardio) che, indipendentemente dalla nostra volontà, si contrae circa 65/85 volte al minuto (battito cardiaco percepibile con la palpazione del polso). A ogni contrazione, il cuore dal ventricolo sinistro spinge il sangue ricco di ossigeno proveniente dai polmoni nell'aorta, mentre dal ventricolo destro pompa nei polmoni il sangue che è ritornato da tutto il corpo carico di anidride carbonica che deve essere ceduta e sostituita dall'ossigeno. Anche l'uscita dei ventricoli è controllata da valvole che non consentono il reflusso nel cuore del sangue espulso. l'aorta è il tronco principale di tutte le arterie, cioè dei tubi (vasi) che diramandosi da essa, vanno a portare il sangue in tutto l'organismo. A sua volta, a livello dei vari organi, il sangue, dopo aver ceduto l'ossigeno, raccoglierà i "prodotti di scarto" del metabolismo (in particolare anidride carbonica), diventerà sangue venoso e, attraverso altri vasi (vene) che corrono parallelamente alle arterie, ritornerà al cuore (parte destra). Da qui andrà ai polmoni, riceverà negli alveoli altro ossigeno per poi ritornare al cuore sinistro e ripetere tutto il ciclo (circolo). Viene detto grande circolo quello che porta il sangue arterioso dal cuore sinistro (ventricolo) a tutti gli organi e che riporta dalla periferia sangue venoso al cuore destro (atrio). Si chiama piccolo circolo quello che dal cuore destro (ventricolo) porta sangue venoso ai polmoni e da questi riporta nuovamente sangue arterioso al cuore sinistro (atrio). I vasi più piccoli, sia arteriosi che venosi, dove avvengono gli scambi (ad esempio con l'ossigeno a livello degli alveoli polmonasono detti vasi capillari. L'apparato circolatorio è strettamente correlato con quello respiratorio, esistendo uno in funzione dell'altro e tutti e due per il nutrimento dei vari organi e fra questi il cervello che è la "centrale operativa" di tutto quello che avviene nel nostro corpo. Una delle situazioni principali in cui vi è un deficit pericoloso nel funzionamento dell'appacircolatorio è lo stato di shock o collasso cardiocircola
SHOCK O COLLASSO CARDIO-CIRCOLATORIO
Le cause di uno stato di shock possono essere diverse: malatcardiaca, perdita di sangue e di liquidi, stimolazione improvvisa del sistema nervospaventi, traumi, dolore molto forte. La caratteristica comune dello shock è il bruabbassamento della presarteriosa, cioè della forza con cui il cuore pompa sangue nelle arterie. Questo repentino abbassamento può portare all'arresto del cuore e alla morte. Se non può essere misurato con l'apposito apparecchio (sfigmomanometro), tuttavia può essere diagnosticato dal soccorritore semplicemente guardando l'infortunato e palpandogli, con due o tre dita della mano, l'arteria del polso (radiale) o del collo, dietro il pomo d'Adamo (polso carotideo). Il paziente colpito da collasso (shock), apparirà all'inizio molto agitato e solo in seguito potrà andare verso la perdita di coscienza e il coma. La cute sarà fredda, pallida e sudata, il polso (carotideo e radiale) veloce, ma debole e difficile da percepire (120/150 battiti al minuto, contro i 65/85 regolari), i movimenti respiratori del torace saranno affannosi (40 atti respiratori al minuto contro i 12/15 normali). Una volta riconosciuto lo stato di collasso cardiocircolatorio, si cercherà di salvaguardare il sufficiente arrivo di sangue al cuore e al cervello, adottando la posizione antishock con il paziente disteso, le gambe tenute sollevate a circa 45 gradi dal soccorritore o mantenute in questa posizione con l'aiuto di coperte, panni arrotolati o di una sedia capovolta.
Gli indumenti stretti, la cravatta, il colletto, la cintura e il reggiseno dovranno essere slacciati. Inoltre, dato che il collassato ha un abbassamento della temperatura corporea, andrà coperto. Una volta chiamati i soccorsi, si sorve-glieranno sempre il polso, i movimenti respiratori, il colore delle labbra e delle unghie. La comparsa di cianosi - colore bluastro - è un indice di aggravamento dello shock. Bisogna essere pronti a intervenire per trattare, qualora si verificasse, un arresto respiratorio e/o cardiaco (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco esterno, pagg. pred. e fig. 6).
Ora è necessario considerare l'eventualità più grave, la vera emergenza dell'apparato circolatorio, cioè l'arresto cardiaco.
ARRESTO CARDIACO
Può precedere oppure seguire l'arresto respiratorio ma, certo, non è possibile che un essere umano continui a respirare se il cuore è fermo o viceversa. Quando il cuore per qualsiasi causa si ferma, entro pochi secondi il cervello comincia a non ricevere più sangue ossigenato. Se resterà in tale condizione per più di 3/5 minuti, si saranno prodotti nelle cellule nervose danni irreversibili che porteranno inevitabilmente al coma profondo e alla morte. Ef importante riconoscere immediatamente l'arresto cardiaco e praticare le manovre atte a far riprendere il battito (vedi massaggio cardiaco pag. 17).
EMORRAGIE
Altre importanti condizioni in cui viene danneggiato, più o meno direttamente, l'apparato circolatorio sono quelle dovute a perdita di sangue dai vasi sanguigni (arterie e vene). La causa di un'emorragia può essere la rottura di un tessuto o di un organo vasco-larizzato, circostanza questa che può verificarsi in quasi ogni tipo di evento traumatico. Le emorragie possono essere esterne (visibili), interne (quando si traumatizzano organi come il fegato o la milza, posti internamente all'addome); interne-esteriorizzate quando sanguinano organi che avendo una comunicazione con l'esterno possono facilmente far fuoriuscire il sangue, ad esempio dalla bocca (ematemesi) per emorragie gastriche o dall'ano per emorragie intestinali (melena). Le emorragie, secondo i vasi sanguigni dai quali sono originate, sono suddivise in venose e arteriose. Per quanto riguarda le emorragie esterne, esse sono sempre generate da ferite.
Emorragie interne. Di fronte ad un'emorragia interna il soccorritore ha ben poco da fare. Il suo impegno deve comunque essere quello di sospettarne e verificarne l'eventuale esistenza ponendo tutta l'attenzione alla possibile comparsa dei segni dello stato di shock (cute fredda e sudata, agitazione, senso di freddo, indebolimento e accelerazione della frequenza cardiaca e del respiro). In questo caso, occorre mettere l'infortunato in posizione antishock e sorvegliare i parametri vitali (coscienza, respiro e polso).
Le cause di uno stato di shock possono essere diverse: malatcardiaca, perdita di sangue e di liquidi, stimolazione improvvisa del sistema nervospaventi, traumi, dolore molto forte. La caratteristica comune dello shock è il bruabbassamento della presarteriosa, cioè della forza con cui il cuore pompa sangue nelle arterie. Questo repentino abbassamento può portare all'arresto del cuore e alla morte. Se non può essere misurato con l'apposito apparecchio (sfigmomanometro), tuttavia può essere diagnosticato dal soccorritore semplicemente guardando l'infortunato e palpandogli, con due o tre dita della mano, l'arteria del polso (radiale) o del collo, dietro il pomo d'Adamo (polso carotideo). Il paziente colpito da collasso (shock), apparirà all'inizio molto agitato e solo in seguito potrà andare verso la perdita di coscienza e il coma. La cute sarà fredda, pallida e sudata, il polso (carotideo e radiale) veloce, ma debole e difficile da percepire (120/150 battiti al minuto, contro i 65/85 regolari), i movimenti respiratori del torace saranno affannosi (40 atti respiratori al minuto contro i 12/15 normali). Una volta riconosciuto lo stato di collasso cardiocircolatorio, si cercherà di salvaguardare il sufficiente arrivo di sangue al cuore e al cervello, adottando la posizione antishock con il paziente disteso, le gambe tenute sollevate a circa 45 gradi dal soccorritore o mantenute in questa posizione con l'aiuto di coperte, panni arrotolati o di una sedia capovolta.
Gli indumenti stretti, la cravatta, il colletto, la cintura e il reggiseno dovranno essere slacciati. Inoltre, dato che il collassato ha un abbassamento della temperatura corporea, andrà coperto. Una volta chiamati i soccorsi, si sorve-glieranno sempre il polso, i movimenti respiratori, il colore delle labbra e delle unghie. La comparsa di cianosi - colore bluastro - è un indice di aggravamento dello shock. Bisogna essere pronti a intervenire per trattare, qualora si verificasse, un arresto respiratorio e/o cardiaco (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco esterno, pagg. pred. e fig. 6).
Ora è necessario considerare l'eventualità più grave, la vera emergenza dell'apparato circolatorio, cioè l'arresto cardiaco.
ARRESTO CARDIACO
Può precedere oppure seguire l'arresto respiratorio ma, certo, non è possibile che un essere umano continui a respirare se il cuore è fermo o viceversa. Quando il cuore per qualsiasi causa si ferma, entro pochi secondi il cervello comincia a non ricevere più sangue ossigenato. Se resterà in tale condizione per più di 3/5 minuti, si saranno prodotti nelle cellule nervose danni irreversibili che porteranno inevitabilmente al coma profondo e alla morte. Ef importante riconoscere immediatamente l'arresto cardiaco e praticare le manovre atte a far riprendere il battito (vedi massaggio cardiaco pag. 17).
EMORRAGIE
Altre importanti condizioni in cui viene danneggiato, più o meno direttamente, l'apparato circolatorio sono quelle dovute a perdita di sangue dai vasi sanguigni (arterie e vene). La causa di un'emorragia può essere la rottura di un tessuto o di un organo vasco-larizzato, circostanza questa che può verificarsi in quasi ogni tipo di evento traumatico. Le emorragie possono essere esterne (visibili), interne (quando si traumatizzano organi come il fegato o la milza, posti internamente all'addome); interne-esteriorizzate quando sanguinano organi che avendo una comunicazione con l'esterno possono facilmente far fuoriuscire il sangue, ad esempio dalla bocca (ematemesi) per emorragie gastriche o dall'ano per emorragie intestinali (melena). Le emorragie, secondo i vasi sanguigni dai quali sono originate, sono suddivise in venose e arteriose. Per quanto riguarda le emorragie esterne, esse sono sempre generate da ferite.
Emorragie interne. Di fronte ad un'emorragia interna il soccorritore ha ben poco da fare. Il suo impegno deve comunque essere quello di sospettarne e verificarne l'eventuale esistenza ponendo tutta l'attenzione alla possibile comparsa dei segni dello stato di shock (cute fredda e sudata, agitazione, senso di freddo, indebolimento e accelerazione della frequenza cardiaca e del respiro). In questo caso, occorre mettere l'infortunato in posizione antishock e sorvegliare i parametri vitali (coscienza, respiro e polso).
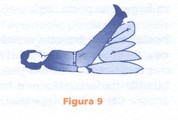
Una possibile presenza di emorragie interne deve essere sospettata ogni volta che vi sia stato un trauma importante del torace o dell'addome. Specialmente a livello dell'addome, dopo urti violenti contro ostacoli di consistenza dura (come negli incidenti stradali con il colpo sul volante) si può verificare la rottura della milza, che può dare emorragie massicce, segnalate soltanto dalla comparsa di uno "stato di shock".
Emorragie esterne venose e arteriose. In un'emorragia esterna è importante riconoscere subito se la stessa è venosa o arteriosa. Nel primo caso il sangue sgorga dai bordi della ferita "travasando" come l'acqua dai bordi di un boccale pieno, colando lungo le pareti della ferita. Invece nel secondo caso, dato che il vaso rotto è un'arteria e le arterie ricevono direttamente l'impulso dalla contrazione cardiaca, il sangue esce dalla ferita a fiotti o a zampilli (a seconda del calibro dell'arteria recisa), sincroni con i battiti cardiaci. Per bloccare un'emorragia venosa, sarà sufficiente tamponare con garze o panni puliti al di sopra della ferita, tenendo eventualmente sollevato in alto l'arto colpito in modo che vi giunga meno sangue per legge di gravità. La compressione andrà mantenuta costante per almeno 5/6 minuti, tempo normalmente impiegato dalle sostanze chimiche del sangue per portare a termine il processo di coagulazione. Nell'emorragia arteriosa invece, sarà più difficile bloccare il flusso di sangue, perchè esso fuoriesce da un'arteria nella quale scorre ad una pressione relativamente alta, dovuta alla contrazione della pompa cardiaca (90 mm Hg di minima e 140 di massima nei soggetti normali, molto superiore fino a oltre 120 di minima e 220 e più di massima, in pazienti ipertesi). Per fermare questo tipo di emorragia bisognerà non solo tamponare con garze o panni puliti più volte ripiegati su se stessi, ma comprimere l'arteria lesa in un punto intermedio fra il cuore e la ferita. Questo punto dovrà essere tale per cui l'arteria possa essere "schiacciata" dall'esterno contro un tessuto duro (un osso o un gruppo muscolare sottostante). Le zone su cui agire sono dette punti di emostasi (vedi più avanti). Le compressioni devono essere fatte con una certa forza e mantenute per molti minuti (5/20), cioè fino a quando il tampone posto sulla ferita non si bagnerà più di sangue. In alternativa all'uso dei punti di emostasi, si potrà impiegare un laccio emostatico (vedi a pag. 110), posto a monte della ferita. Questo però può dar luogo a delle complicazioni perchè, se un blocco alla circolazione arteriosa viene mantenuto per troppo tempo, il mancato arrivo di sangue ai tessuti può provocare danni. Perciò il laccio emostatico, ogni quarto d'ora circa, dovrà essere allentato con cautela, per poi restringerlo dopo qualche secondo se l'arteria sanguina ancora.
Punti di emostasi. Possiamo definire sulla superficie del corpo alcuni punti dove, esercitando una compressione decisa e mantenendola tale per almeno 5 minuti, ma non oltre 20 senza interruzione, possiamo fermare un'emorragia esterna arteriosa, anche senza l'aiuto di un "laccio emostatico". Per le emorragie arteriose di tutto l'arto inferiore il punto di emostasi elettivo è alla regione inguinale,nella parte interna dell'attaccatura della coscia, a metà circa della linea inguinale dove si può percepire il battito dell'arteria femorale.

In caso di emorragia distale dell'arto inferiore (piede), ci si potrà limitare a fare una pressione subito dietro la protuberanza del malleolo interno alla caviglia.
Per le emorragie arteriosi dell'avambraccio, il punto d emostasi è sull'arteria omerale al di sotto della linea inferiore del muscolo bicipite (fig 26) lungo la faccia interna del braccio fra l'ascella e la piega del gomito.

Le emorragie di tutt l'arto superiore e dell spalla, del braccio in particolare si bloccheranno, invece comprimendo l'arteria ascellare che corre nel cavo dell'ascella o l'arteria succivia che può essere raggiunta dietro la clavicola, nell'incavo anteriore della parte alta del torace. Quest'ultima va premuta con il pollice contro la sottostante prima costa, sp gendo dall'alto verso il basso in direzione dei piedi.(fig27)
 Le emorragie arteriose delle grosse arterie del collo, anche se sono sempre difficili da arrestare senza intervento chirurgico, si potrà tentare di fermarle comprimendo l'arteria carotidea nella sua parte iniziale, dietro la clavicola, come nel punto di emostasi della succlavia (fig. 29), ma più vicino allo sterno. E' opportuno comunque ricordare che, per acquisire la manualità di tali "punti di emostasi", sarà essenziale abituarsi a riconoscere, anche su se stessi, mediante la ricerca della pulsazione, il punto dove passa l'arteria interessata.
Le emorragie arteriose delle grosse arterie del collo, anche se sono sempre difficili da arrestare senza intervento chirurgico, si potrà tentare di fermarle comprimendo l'arteria carotidea nella sua parte iniziale, dietro la clavicola, come nel punto di emostasi della succlavia (fig. 29), ma più vicino allo sterno. E' opportuno comunque ricordare che, per acquisire la manualità di tali "punti di emostasi", sarà essenziale abituarsi a riconoscere, anche su se stessi, mediante la ricerca della pulsazione, il punto dove passa l'arteria interessata.Emorragie ginecologiche (metrorragie). Da non confondere con il normale flusso di sangue mestruale, possono essere anche gravi in corso di aborto o per malattie degli organi genitali. Nelle metrorragie# il soccorritore dovrà limitarsi a far mantenere alla donna la posizione sdraiata, con la testa più bassa del bacino e delle gambe che vanno tenute piegate "ad arco" sostenendole con coperte arrotolate o cuscini posti sotto le ginocchia. Applicare una borsa di ghiaccio o acqua molto fredda sul basso ventre per provocare vasocostrizione e così fermare o rallentare l'emorragia.
Emorragia nasale (epistassi). E' opportuno tenere la testa chinata in avanti, per evitare che il sangue defluisca
Home Page | Associazione | Uomo | Animali | Ambiente | Cinofilia | Servizi | Foto & Video | Comuni | Regione T. | Mappa generale del sito








